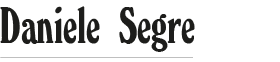www.redattoresociale.it
“Quando entri non sai mai cosa ti succede, vorresti solo dormire ma non ce la fai. Senti un rumore, pensi di essere a casa, e invece sei in una cella piccola come un bagno. Quando ti svegli, dopo la prima notte, sembra siano passati vent’anni”. E’ una lenta discesa dentro la sofferenza umana quella che ci porta dentro il carcere fiorentino di Sollicciano, nel documentario Sbarre, realizzato dagli studenti del Centro sperimentale di cinematografia con la supervisione del regista Daniele Segre. Un racconto dall’interno di uno dei drammi italiani, tristemente noto e costato al nostro paese la condanna da parte della corte europea europea per i diritti dell’uomo (sentenza diventata esecutiva il 28 maggio scorso). Ma a dirci quello che in parte sapevamo già sullo stato malsano del nostro sistema carcerario sono, questa volta, gli stessi detenuti, attraverso le interviste realizzate dagli studenti del laboratorio tenuto da Segre.
E così con una voce sola, che parla anche per gli altri 60 mila detenuti sparsi nel resto del paese, ci raccontano le condizioni igieniche disumane in ci si trovano a vivere: “i bagni sono un metro per tre, non c’è neanche il bidet. E nel materasso ci trovi spesso le tarme”. Quello che manca, però, non è solo un posto decoroso in cui scontare la pena, ma anche il lavoro, a cui la maggior parte ambisce per distrarsi e per avere un’opportunità di reinserimento una volta fuori. “Ormai hanno tagliato quasi il 50 per cento del lavoro in carcere, e ci scanniamo tra di noi per avere qualcosa da fare. Ma se mi tieni qui senza fare niente per vent’anni, una volta fuori che vuoi che faccia? Tornerò a delinquere perché altro non so fare”.
E mentre i giorni passano troppo lentamente e in modo ripetitivo, si perdono a mano a mano anche le parole. “Il vocabolario per tutti si restringe, subiamo un’omologazione nel linguaggio e nel pensiero perché facciamo e diciamo sempre le stesse cose”. Quello che emerge, dunque, è una critica feroce a un sistema, che di fatto non riabilita, e dove è quasi impossibile vivere senza impazzire, l’unico modo- spiegano – “è non pensare al tempo che devi scontare qui dentro. Alla fine, però, in ogni cella abbiamo due o tre calendari”.
Ma in questo racconto corale di una pena che sembra non finire mai, c’è anche uno spiraglio di speranza, negli affetti che sono fuori ( figli, madri, compagni) e in quelli incontrati proprio dentro. Nel carcere di Sollicciano, infatti, non sono rari gli amori tra le sbarre, perché il penitenziario maschile e quello femminile si trovano l’uno di fronte all’altro. E così uno sguardo dalla finestra diventa il presagio di una storia, che si sviluppa con la tecnica del “panneggio”. Attraverso i panni fatti volteggiare fuori dalle finestre, infatti, i detenuti si parlano in un linguaggio d’amore in codice che solo loro conoscono e conservano gelosamente.
Per il documentario, gli autori hanno scelto la tecnica dell’intervista multipla. I detenuti appaiono allo spettatore senza alcun artificio estetico e senza che si sappia che tipo di storia hanno alle spalle. “Abbiamo voluto rappresentarli solo come persone – spiega Daniele Segre – senza nessuna volontà di mistificare la realtà, perché quello che intendevamo realizzare era un viaggio di verità e condivisione. Usare artifici estetici per questi volti già così interessanti e belli sarebbe stata un’inutile strumentalizzazione”. Gli incontri tra gli studenti e i detenuti si sono svolti in quattro giorni. “Siamo riusciti a tirar fuori un racconto così reale – aggiunge – perché abbiamo ottenuto di intervistarli da soli. Si è trattato di un incontro vero tra persone che avevano voglia di raccontarsi”. Il progetto iniziale, però, era un altro – spiega una delle autrici del film, Francesca Mazzoleni: “Avremmo dovuto raccontare un concorso di band emergenti che si è svolto nel carcere. Ma quell’occasione è stata piuttosto il nostro cavallo di Troia, perché una volta dentro abbiamo realizzato queste interviste così cariche di umanità. E così la forza delle parole dei detenuti ci ha convinto a fare un lavoro diverso. Un flusso di racconti dove non ci sono nomi né storie personali, ma dall’interno si narra una condizione che unisce tante persone in tutto il paese”. (ec)